
Dialogo epistolare con il M.° Francesco Rampichini dopo la pubblicazione del suo nuovo libro
Quando Francesco mi parlò l’anno scorso dell’imminente uscita del suo nuovo libro, Il pasto di Krónos, dedicato alla relazione tra musica e linguaggio, fui subito colto da interesse per il tema trattato e da curiosità per il modus espositivo con cui avrebbe sostenuto l’analisi del raffronto. Sapevo già del suo forte diniego nel ritenere la musica un “linguaggio universale”, come sempre più comunemente viene considerata, e in effetti mi confermò che il suo lavoro trattava nello specifico anche questo argomento. Ribadì il fatto che la musica non può essere considerata un linguaggio, in quanto il suo manifestarsi conosce un’evoluzione diversa da quella della parola. Di primo acchito pensai che la popolarità di tale affermazione fosse dovuta a una sorta di tropo analogico e di conseguenza, mi si perdoni il gioco di parole, a una sovrastruttura di linguaggio che può adulterare il vero creando per effetto una falsa certezza.

Mi venne alla mente l’opera Mozzarella in carrozza del 1970 di Gino De Dominicis, che ebbi occasione di vedere nella mostra Dadaismo dadaismi. Da Duchamp a Warhol tenutasi nel lontano 1997 presso Palazzo Forti di Verona. Non si tratta di una raffigurazione scultorea del celebre piatto napoletano, ma di una mozzarella fresca posta sui sedili lussuosi di un’autentica carrozza d’epoca. Se da un lato l’autore voleva forse porre un richiamo beffardo all’imperante concettualismo delle neoavanguardie in fil rouge con le Avanguardie Storiche, pur essendo lui un seguace di Marcel Duchamp, dall’altro il suo lavoro sottolinea una forte provocazione ironica sulle costruzioni linguistiche che non portano all’enunciazione del vero, ma a una raffigurazione simbolica come la metafora che il nome dato al piatto costituito da formaggio, latte e pane genera. Per lo stesso motivo per cui la mozzarella adagiata tra due fette di pane, in origine di forma rotonda come una ruota, non è realmente “in carrozza”, la musica non può essere definita un linguaggio, tantomeno universale, al solo soddisfacimento di una costruzione intellettuale che vede come tale qualsiasi espressività umana (lo stesso si potrebbe infatti dire di danza, pittura, e via discorrendo). Dopo che ebbi l’opportunità di leggere il saggio e mi addentrai nell’esposizione del tema, rilevai che in realtà vi era molto di più di una semplice critica concettuale, ma per ragioni proprie che in origine accomunano il suono della parola alla musica definire questa un “linguaggio” comporta equivoci ed errori valutativi sulla natura del suo evolversi che giustamente Francesco Rampichini sente il dovere di denunciare apertamente. Non solo: il libro si rivela nella sua lettura una vera fucina di stimoli che non lo fa rientrare, per quanto autorevoli, tra i semplici compendi di una disciplina. Il suo libro non indica come fare musica, ma illustra in modo chiarificatore che cos’è la musica e attraverso lei dove l’uomo può arrivare a immaginare l’universo che lo circonda. Non esprime dunque opzioni esecutorie, modificazioni agogiche, definizioni cattedratiche su ciò che la musica deve conferire all’ascoltatore. Al contrario, si rivolge proprio a colui che recepisce il contenuto musicale e lo avvicina a un’attitudine ricettiva fino a quel momento mai affrontata se non con superficialità. Antonin Artaud, con il suo Il teatro e il suo doppio (Le Théâtre et son Double, 1938) supera la letterarietà dell’opera teatrale a favore della vitalità esperienziale dello spettatore a livello sensoriale per un altro tipo di teatro che non può più essere ritenuto di semplice rappresentazione. Allo stesso modo Rampichini è riuscito a suscitare in me un interesse verso la facoltà della musica che viaggia ben oltre la stessa intenzione espressa nel sottotitolo del libro (Musica e linguaggio. Antidoti a un’aporia analogica), quasi che l’incipit del trattato servisse da innesto per qualcosa di più ampio, elevato, verso inesplorati confini della conoscenza. L’autore che, occorre ricordarlo, è compositore, musicista e docente nonché prezioso redattore di Punto e Linea Magazine, è colui che ha ideato l’Acusmetria, neologismo che indica il «codice delle proporzioni geometriche nella rappresentazione acustica della prospettiva spaziale». Un inventore e creativo di alta statura che è riuscito a far “sentire” la musica come componente indispensabile dell’esistenza. Se per Nikola Tesla i segreti dell’Universo vanno pensati in termini di energia, vibrazione e frequenza, Rampichini sembra voler completare il quadro euristico con il ritmo cadenzato e sonoro che la musicalità esprime. Addentrarmi nel suo saggio ha incentivato in me il desiderio di un percorso di approfondimento da condividere con lui. Non riuscendo a incontrarci fisicamente, ci accordammo per uno scambio epistolare, al fine di esprimere con i miei quesiti, dissertazioni e le sue risposte un focus sulle diverse tesi trattate nel libro.
Claudio Elli – Ciao Francesco, grazie per aver intrapreso con me questa piccola odissea epistolare, che mi ricorda in forma indiretta gli albori della nostra trentennale amicizia, i nostri lunghi colloqui su musica, poesia e società, seduti al bancone di un’osteria sui Navigli con un boccale di birra in mano.
Inizio il nostro cammino sul tuo appassionante saggio.
A prescindere dall’intenzione dichiarata di fugare alcuni preconcetti sulla musica (in particolare il conclamato ritornello non scevro da banale intellettualismo che la identifica come “linguaggio universale”), per la quale sarebbe tuttavia bastato un articolo di diniego nei confronti di qualsiasi stereotipo fuorviante, il tuo libro mi è sembrato molto di più, anche rispetto una lectio magistralis di semantica delle espressività, non scevro da connotati filosofici. Qual è stata la scintilla che ti ha spinto a questa sofisticata e a parer mio affascinante elaborazione?
Francesco Rampichini – Mi fa piacere che tu colga un contesto più ampio della semplice opposizione a un luogo comune, che in effetti è un innesco. La mia intenzione non era tanto dire cosa la musica non sia, quanto sollevare il velo su ciò che è – o almeno che è stata nella mia esperienza – e su come ho vissuto il senso della meravigliosa avventura che rappresenta. Un inestinguibile desiderio di conoscenza mi ha sempre spinto ad attorniarmi di amici dalle più diverse formazioni: fisici, architetti, filosofi, pittori, non solo musicisti. Parlare di musica con cultori di altre discipline può essere un esercizio interessante, perché tra musicisti si danno spesso per scontate cose che non lo sono per nulla. La bella esperienza di docenza al Politecnico di Milano – cinque anni importanti all’inizio del secolo in una materia definita forma/suono – mi costrinse a mettere nero su bianco cose che non sapevo di sapere, che emergevano affrontando temi interdisciplinari. Come racconto nel libro, fu in quel contesto che nacque l’acusmetria. Per tornare alla tua domanda, la scintilla è stata il desiderio di rispondere, su basi esperienziali e non per proverbi, alla domanda “cos’è la musica?”. La gran parte dei testi sull’argomento s’inerpica in idilliache descrizioni di emozioni, allusioni bucoliche, nessi biografici. Ma se cambi il titolo alla “Sonata Patetica” – dato dall’editore, non da Beethoven – e la chiami “Sonata Volo di notte” cambia il suo senso? Prova. Ti accorgerai di sì, se badi al nuovo titolo. Ti accorgerai di molto altro, se cassi del tutto il titolo. È dunque nel significato di una parola descrittrice a posteriori, il senso della musica? No, è in altre dimensioni più stupefacenti, pregnanti e al tempo stesso tangibili, se si accetta di cambiare territorio, stato, come cerco di chiarire nel libro.
C. E. – Ti rivolgo una domanda inerente il titolo. Il tuo Krónos (Κρόνος), figlio di Urano e Gea, è un dio antico preolimpico legato alla fertilità, il tempo e l’agricoltura, in pratica un titano che come il padre voleva sopprimere i suoi figli a causa della predizione di un oracolo circa la sua detronizzazione da parte di uno di loro. Non potendo uccidere i neonati poiché come lui immortali, il dio li ingoiò, a parte Zeus sostituito dalla madre Rea con una pietra che in effetti spodesterà Crono facendogli rigurgitare anche i fratelli già divorati. Pasto macabro a parte, ricordato in un suggestivo quadro di Francisco Goya, e al di là della “sindrome di Crono” o “di Saturno” relativo il desiderio di un padre di uccidere il proprio figlio, Il pasto di Krónos suggerisce l’ermeneutica di una mitografia, che nel sottotitolo si deduce quale strumento per l’elaborazione, nella definizione di musica e linguaggio, di antidoti a un percorso aporetico. Puoi illustrare il motivo conduttore della tua scelta e il legame con Kairós, caro ad Aristotele e significativo nell’antica Grecia del “momento opportuno”?

F. R. – Questo libro è nato durante il periodo di isolamento da Covid, drammatico per certi aspetti ma non privo di ricadute positive. Per me, una lunga pausa di riflessione durante la quale riordinare cassetti e idee. In un primo tempo volevo intitolarlo “Musica e linguaggio”, poi passai a “Musica è linguaggio?”. Mandai le prime bozze a vari editori, che in qualche caso mi fecero cortesemente sapere che si trattava di un testo troppo “di nicchia”. Altri, come si usa, nemmeno risposero. Mentre cercavo una destinazione editoriale – poi felicemente trovata in casa Biblion – mi confrontavo con i preziosi amici citati nei ringraziamenti, rendendomi conto che un titolo più seducente avrebbe aiutato. Mi frullavano in mente i versi di Ovidio “tempus edax rerum” e l’impressionante, indimenticabile tela di Goya Saturno devorando a su hijo che vidi al Prado nel secolo scorso. Uno dei fenomeni che la musica mette in atto è nutrire il tempo di un cibo “non terrestre”, per citare Da Ponte, portandoci in uno spazio non solo non colonizzato dal logos, ma estraneo al tempo calcolabile dell’orologio. Così mi chiesi, cosa divora questo tempo? Dove e quando finisce il pasto? La musica muove le marmoree mandibole di Krónos e il cibo siamo noi. Irrompe come in una maglia troppo stretta nel nostro tempo quotidiano e lo deforma, lo trasfigura e trascende: non sono gli uomini o le cose a vivere nel tempo, ma è il tempo nelle cose, in ciascuno in modo differente per quantità e qualità. Questo ammontare finito di energia che ci occupa e trascorre dentro, ingaggia in molte forme la nostra sensorialità. Non tutti hanno la sorte di distinguerne la natura. La musica è una grande occasione per infilare collane di Kairós, perché per essere vissuta obbliga a tenere insieme passato, presente e futuro: devo ricordare ciò che ho sentito mentre ascolto ciò che sento, per connetterlo con ciò che sentirò. È la condizione per coglierne forma, direzione, senso. Quanto all’aporia, è il risultato delle redini disuguali con cui gran parte degli analisti e dei musicologi conducono la corsa, a metafore sciolte. Con gli strumenti della linguistica non si abbraccia né si comprende la musica, si cavalca un mostro a due teste, in un vicolo cieco pieno di aggettivi in cerca di un “onto”.
C. E. – Interessante la tua osservazione sulla musica legata alla voracità di Krónos, mi suggerisce una riflessione sulla facoltà della musica d’interpretare una diversa modulazione della nostra stessa esistenza. Se dal punto di vista linguistico la dottrina che decodifica i caratteri universali di un ente è l’ontologia, prima filosofia di un maturo Aristotele che dà poi luogo alla metafisica, abbiamo di contro l’essere concepito come Evento che si dà all’uomo in un rapporto di completa fruizione, attraverso una fase del pensiero di Heidegger che affronta la verità dell’essere, per cui il “prefisso ontologico” è superato dal perfezionamento della tecnica che porta a un “nascondimento”. Se si corrisponde all’essere come evento, la stessa filosofia si trasforma nel «pensiero della storia dell’essere». Voglio immaginare che questo Evento sia connaturato con la musica nel dis-velamento della verità, che però tu poni come motrice delle mandibole di Krónos mentre mastica il cibo costituito da noi. In sostanza, per te la musica può essere componente della fruizione umana oppure, perdona la provocazione, è l’uomo a essere l’Evento di cui la musica è fruitrice?
F. R. – Concordo sul fatto che la musica offra l’occasione di interpretare una diversa modulazione della nostra esistenza. Pensare l’uomo come evento di cui la musica sia fruitrice è una visione per così dire “animista” non priva di suggestione, ma è una “scuffiata”, un capovolgimento forse utile per osservare le cose da un’altra prospettiva. Certo è che la musica – se non si crede alla discendenza divina di Orfeo e all’esistenza di Apollo – sia un’invenzione umana. Quindi con una pistola alla tempia direi che è vero il contrario, cioè che la musica sia l’evento di cui l’uomo è fruitore. Ma la tua provocazione non è priva di implicazioni di natura filosofica sulle quali riflettere.
C. E. – In un passo hai scritto quanto l’applicazione rigida di regole matematiche in musica possa generare un limite creativo. Ciò ci riporta da Tartini con il fenomeno del “terzo suono” alle relazioni più astratte con quelle scienze che studiano i numeri, rispetto alle condotte musicali più vicine alla fisica, come l’acusmetria di cui sei ideatore e sulla quale ti chiederò approfondimenti. Nel tuo ultimo capitolo, unitamente a una disamina su Schönberg e lo “sposalizio” (Sprechgesang) fra parti recitate e quelle cantate nel Pierrot Lunaire, nello smorzare la dicotomia tra pathos e ratio con la ricongiunzione tra la via sensoriale per la messa in atto della logica e viceversa, entri nella definizione della Sezione Aurea con la costante di Fidia φ (il rapporto estremo e medio di Euclide) corrispondente a 1,618 e la successione numerica di Fibonacci. Oltre alla larghezza del viso e distanza tra gli occhi, questa “sequenza”, presente in numerose opere figurative e architettoniche odierne come nel passato, è stata utilizzata per la struttura delle battute nel pezzo dei Genesis Firth of Fifth del 1973. Non pensi, al di là di una logica matematica della bellezza (che giustamente può rivelarsi al di là di questa sequenza), che la Sezione Aurea definisca una perfezione nella quale possa trovare dimora anche la musica?
F. R.– La bellezza si ritrova molto al di là di questo evergreen. È forse – come dicevano Schiller e un mio vecchio amico d’oltrecortina, con i quali da giovane dissentivo – l’esca dietro la quale si cela la verità, una possibile via d’accesso ad essa. In musica, le cosiddette proporzioni auree sono state molto utilizzate, ma sfido chiunque ad accorgersene ascoltando Bach, Beethoven, Bartók o Debussy, per citare alcuni tra i compositori che le hanno variamente incorporate nelle loro opere, Genesis inclusi. Utilizzare questo strumento per edificare la propria struttura è possibile: ma può, anche il più grande architetto, riconoscere la qualità del cemento di fabbricazione di un ponte guardandolo? Io non ci ho mai nemmeno provato. Comunque le cito in forma dubitativa, perché non credo che tutte le forme rispondenti a questa affascinante teoria delle proporzioni ci attraggano indistintamente per la loro bellezza. Ci sono in natura cose di proporzioni auree che trovo repulsive. Personalmente non ne ho mai fatto uso, ma ognuno segua il proprio dáimōn.
C. E. – Ho trovato molto pertinente nel terzo capitolo, “Y”, il tuo riferimento al pensiero di Darwin. Se musica e linguaggio possono essere collegati in evoluzione da una “particella” con la struttura di una corda, con un gioco che riporta alla fisica quantistica e la teoria delle stringhe, la divaricatrice Y che tu poni come schema si trasformerebbe nella raffigurazione stilizzata di un calice pieno. A un certo punto parli di “esploratori” che risalgono la corrente verso il centro della Y spogliandolo da ogni suono concreto del linguaggio. Oltre a Joyce, di cui sappiamo la sua forte affinità con la musica al punto da essere stato in gioventù un aspirante tenore, citi Carmelo Bene, che definì la phoné come rumore, che comprende anche la musica e il dire. Vorrei soffermarmi su questo secondo personaggio, affine con la sua scrittura di scena a quel théâtre de la cruauté coniato da Antonin Artaud dove viene agito il non-attore nel dis-fare anziché nel fare, dando luogo a una macchina attoriale quale conseguenza di quel “grande attore”, svestito dalle sue umane capacità corporee, con un’amplificazione di voce e funzione visiva. Non solo la voce diviene suono, ma anche «l’occhio è ascolto». In quel luogo che tu descrivi lungo il “gambo della Y” dove il linguaggio (ti riporto testualmente) «può illuminare alcuni tragitti alle sorgenti della musica» non pensi possa risiedere la frequenza di una sophia universale quale fluido di riempimento del calice? Sarebbe la fine dell’aporia.

F. R.– Io non so se esista una “conoscenza universale”. So che il sensibile porta a conoscere la realtà entro i limiti della nostra possibilità di percepirla e capacità di interpretarla. La fine dell’aporia potrà forse stare nel riempire il calice che tu vedi nella mia schematica rappresentazione d’una divaricazione. Questa però non indica un conflitto tra musica e linguaggio, ma un mutamento di stato. La tua metafora mi piace, il problema è che per trasformare un trivio in un calice bisogna prima sigillare le uscite. Quando getto nel calice del ghiaccio questo è solido, piano piano cambia stato ed eccolo svanire, perdere forma e consistenza. Che succede? È scomparso? Lo faccio dire da Rimbaud:
Elle est retrouvée.
Quoi ? – L’Eternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil.
Cercare il significato nella musica è come cercare il cubetto disciolto nel calice. È il processo che conta. In questo senso quel cubetto siamo noi, tetragoni, gettati nel calice della musica: faremo parte della soluzione o resteremo bloccati a zero gradi?
C. E. – Il mare che si accompagna e si “mischia” al sole ne L’Eternité mi porta a una sorta di abbandono, un passaggio che solo un’elevata capacità metacognitiva può arrivare a concepire, al di là delle motivazioni immanenti che spinsero il poeta all’elaborazione di quei versi. Una consapevolezza che si ammanta di ritmo, conoscenza delle frequenze, in altre parole di una melodia eterea che non tutti riescono a recepire e a far propria nell’affrontare il consueto attraverso lo straordinario. La frizione tra il cubetto bloccato a zero gradi e il suo discioglimento genera il conflitto nella drammaturgia dell’intimo processo alchemico, che anche in questo caso risolve Rimbaud in Guerre con C’est aussi simple qu’une phrase musicale. Tu stesso, parafrasando Giordano Bruno, nel descrivere una staticità elementale e una ridestabilità funzionale con il confronto tra il Mosè di Michelangelo e il Miserere di Allegri, parli di un cammino oltre ogni presunto limite, verso un luogo che mi ricorda l’orizzonte di Lovecraft quale punto infinito dove il mare incontra il cielo. Non credi che la musica possa essere uno strumento escatologico che definisce il diaframma coscienziale tra immutabilità e trasmutazione?
F. R.– Mi piace pensare che sia come dici. Ma affinché la musica operi un cambiamento, influisca sul nostro “destino”, occorre un atto di volontà sostenuto da un minimo di cultura specifica, per non ridurre la sua esperienza al subire passivamente il verificarsi di un evento. Credo che sia un potente strumento di trasformazione, o almeno lo è stato e lo è per me. Ma al di là dei processi profondi, individuali e delle loro implicazioni filosofiche, potrei citarti moltissimi casi che dimostrano il suo potere d’influenza sul sociale. Dalle mie esperienze personali in quella che chiamavamo “educazione musicale permanente” con l’apertura serale del Conservatorio di Milano, fino a El Sistema di Antonio Abreu, nel quale la musica assume il ruolo di via primaria per un’emancipazione intellettuale collettiva e condivisa, con la Foundation for the National Network of Youth and Children Orchestras of Venezuela.
C. E. – Vorrei tornare all’acusmetria e alla sua funzione correlatrice tra modelli sonori e forme geometriche. Nell’introduzione del libro dedicato all’argomento (Acusmetria. Il suono visibile, Franco Angeli Editore) parli di “materiali a memoria di forma” come le leghe intermetalliche a base di Nichel-Titanio, ovvero di quei “materiali intelligenti” dotati di elevate elasticità e capacità di smorzamento delle vibrazioni, le cui caratteristiche furono propedeutiche alla tua ricerca con l’intenzione di stabilire un rapporto tra suono e segno grafico, grazie all’associazione di “oggetti sonori” con un disegno identificabile. Un connubio suggestivo che rivedo, ne Il pasto di Krónos, con la descrizione dello spazio acusmetrico. Il fatto che la musica, appunto perché avulsa da quella semiotica già cara a Vico piuttosto che De Saussure, risulti estranea al nesso tra significato e significante, i parametri utilizzati nell’acusmetria mi richiamano un altro “nesso di causalità” tra le architetture, quali per esempio le prospettive rinascimentali a cui fai riferimento, e il suono. Può questa connessione riportare agli stessi modelli sonori l’origine antropologica dello spazio tridimensionale che l’uomo ha costruito nei secoli, al pari del linguaggio?
F. R.– La percezione dello spazio nel quale ci muoviamo è fortemente connessa all’udito, quindi al suono. Noi siamo perennemente immersi nella radiazione acustica e ogni fenomeno sonoro rivela qualcosa sulla sua fonte e sull’ambiente. Se entri al buio in un locale con pareti piastrellate, ne indovini la natura dal riverbero che produce. Suono e spazio sono in una relazione inscindibile. Di una voce alle tue spalle puoi valutare, su basi esperienziali, a quale distanza si trovi il suo emettitore. Ma oltre alla posizione puoi indovinare sesso, etnia, persino grado di cultura e intenzioni del suo portatore, sulla base delle curve intonative e di altri elementi di carattere prosodico. L’acusmetria è un’altra avventura, è il codice delle proporzioni geometriche nella rappresentazione acustica della prospettiva spaziale. Crea un legame biunivoco tra segno acustico e segno grafico e come tutti i codici richiede un certo grado di apprendimento e di consentaneità. Pochissimi per la verità, dato che tutti gli esperimenti condotti indicano che si tratta di un fenomeno sovra culturale e praticamente immediato, almeno per la percezione delle sue forme più semplici. L’ho a volte utilizzata per mie composizioni ed altre per progetti come “Sentire le stelle”, sviluppato in collaborazione con il Planetario di Milano, nel quale ho acusmetrizzato le astrocartografie di molte costellazioni per permettere anche ai non vedenti di coglierne le configurazioni proiettate su quello che chiamo “schermo uditivo”. Un’esperienza bellissima che ho portato più d’una volta all’Istituto dei Ciechi di Milano, anche all’interno di “Dialogo nel buio”, e che conto di riprendere presto per portarla a un pubblico più allargato. Ma questa è un’altra storia.
C. E. – Un grandioso progetto, che van ben oltre il semplice stereotipo dell’”inclusività” e che mi richiama lo sviluppo di una percezione multisensoriale, di cui ti faccio i miei complimenti. Il suono e lo spazio, correlati alla cultura specifica che la musica può generare come elemento di trasformazione, mi suggeriscono un ulteriore “genoma” dell’anima, o se preferisci un’alterazione coscienziale determinata da un diaframma gnostico e cognitivo. Gli appunti di Darwin che tu menzioni evocano un prelinguaggio “musicale” quale fondamento di un modello di evoluzione del linguaggio. Di conseguenza la musica è connaturata all’antropologia e agli stilemi di un contesto primigenio. Ha senso quindi oggi sviluppare generi musicali che hanno radici altrove e di conseguenza hanno maturato una diversa identità linguistica? Fra questi mi riferisco al rap di origine africana e peggio ancora al trap legato alla droga nato nel sud degli Stati Uniti, e che senso possano avere in lingua italiana, vista la loro origine avulsa dalla nostra cultura umanistica e musicale…
F. R.– Ne “Il pasto di Krónos” cerco di spiegare come musica e linguaggio condividano una scaturigine, una sorgente. Non è che uno discenda dall’altra, ma si sviluppano a partire da dispositivi comuni. È un tema di fondo del libro. Quanto ai “generi musicali”, dalla fine della seconda guerra l’Italia è una colonia anglo-americana. Nel corso degli anni, tra Donald Duck e Donald Trump, ci hanno colonizzato jazz e country, pop e rock, punk e metal, fino alle raffinatezze che citi, rap, trap e via così. Tuttavia non si può non vedere la voragine, in termini di qualità e contenuti, tra Beatles o Pink Floyd e la musica di consumo di oggi. Se parli di “cultura musicale”, “origini”, “identità”, i veri bacini della nostra musica popolare sono la canzone napoletana, la canzone di battello veneziana, le scuole sarde di launeddas, per citarne tre. La “globalizzazione” è un fenomeno inarrestabile, con aspetti anche positivi. Il punto è che non ci piace ciò che non capiamo. E per capire uno stolto che mugola stoltezze serve una massa di stolti. Questo chiede e produce il mercato, perché costa pochissimo e rende moltissimo. Tutte le mode hanno però un pregio: passano. Se la nostra generazione doveva fare chilometri o trascorrere giorni in polverose biblioteche per trovare risposte, oggi chiunque lo desideri ha accesso a capolavori e conoscenze in ogni ramo del sapere, a portata di mouse. L’ignoranza è quanto mai una responsabilità individuale. Il problema per i naviganti è trovare la via. La cultura richiede qualche impegno ma, se si scopre la gioia che riserva, diventa un moltiplicatore di civiltà senza paragoni. Esattamente come le mode deteriori, con i loro sottoprodotti rovesciati sulle masse per ragioni di profitto, moltiplicano la barbarie. Ognuno scelga da che lato far pendere la bilancia. Punto e Linea ha fatto la sua scelta, senza dubbio quella giusta.
C.E. – Un percorso, quello di Punto e Linea, avvalorato dal tuo contributo. Credo comunque che con questo dialogo abbiamo creato il presupposto di un confronto armonico, forse l’inizio di un possibile laboratorio di idee che può un domani, su questo come altri argomenti attigui, dar luogo a un autentico forum con più soggetti. In un periodo in cui il dibattito sembra emarginato a favore di correnti univoche di pensiero, le nostre riflessioni hanno posto almeno la liceità del dubbio rispetto ad affermazioni che paiono granitiche, ma che in realtà sono il frutto di superficialità condivise, e il tuo libro costituisce certo una pietra miliare per ripensare all’importanza della musica senza incorrere in definizioni pregiudiziali erronee. Complimenti e arrivederci a un prossimo approfondimento, sempre foriero di ricchezza conoscitiva. E magari, stavolta, davanti a una buona birra …
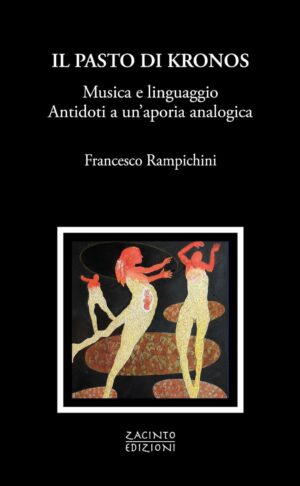 Francesco Rampichini
Francesco Rampichini
IL PASTO DI KRONOS. Antidoti a un’aporia analogica
Zacinto Edizioni, 2023
ISBN 978-88-31323-44-4
